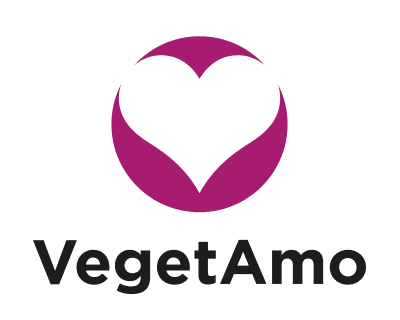COP26: La politica e il clima
foto di Mika Baumeister recuperata da Unsplash
In queste settimane i riflettori di tutto il mondo si sono puntati su Glasgow, per un incontro diplomatico globale in cui si riponevano grandissime speranze. Presidenti e ministri di ogni Paese si sono raccolti per definire le linee guida che il mondo adotterà nel prossimo futuro per affrontare la crisi climatica, in occasione della 26° Conferenza delle Parti, o in breve COP26. Tra critiche, lodi e pettegolezzi, è sicuramente interessante analizzare ciò che è emerso durante queste due settimane di convegni e capire il vero significato di questa riunione diplomatica globale.
Per cominciare, è importante capire cos’è una COP, e chi vi partecipa. Le COP raccolgono tutti i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), ratificata nel 1992 e che oggi raccoglie 197 parti, cioè tutti i Paesi riconosciuti dall’ONU e l’organismo dell’Unione Europea. Il patto prevede riunioni periodiche tra le parti, in cui si prendono accordi per contrastare il riscaldamento globale: precedenti illustri sono il protocollo di Kyoto della COP3 (1997) e gli accordi di Parigi della COP21 (2015). La COP26 si è posta come occasione di aggiornamento di entrambi questi trattati, e in particolare di quello di Parigi, di cui ha chiuso molte questioni ancora incerte. Prima dell’apertura dei lavori, sono stati definiti in particolare quattro temi chiave attorno ai quali catalizzare le discussioni:
- Ridurre le emissioni di gas serra
- Salvaguardare ecosistemi e comunità dai danni del riscaldamento globale
- Trovare finanziamenti per la transizione ecologica
- Stabilire criteri per favorire la collaborazione tra Stati, società e imprese
Obiettivi sicuramente ambiziosi, che si sono concretizzati in due settimane di incontri che hanno prodotto diversi trattati (non ratificati da tutti i Paesi) e un accordo finale tra tutte le parti, il Glasgow Climate Pact. In esso si è cercato di sintetizzare lo spirito della discussione e si sono ripresi uno ad uno tutti i temi chiave, con punti di continuità e di innovazione rispetto al passato, a partire dai principi ispiratori.
Fin da subito, infatti, si è ribadito che la base della COP è il principio di “comuni ma differenziate responsabilità” e il riconoscimento dei dati scientifici sulla questione climatica. Il primo punto fu teorizzato già nel protocollo di Kyoto; si tratta del criterio attraverso cui si stabilisce quali parti debbano portare l’onere della transizione. I Paesi più sviluppati hanno inquinato di più in passato, e hanno quindi più obblighi rispetto a quelli in via di sviluppo. Questo risponde sia alla necessità di commisurare lo sforzo di un Paese alla sua disponibilità finanziaria, sia all’osservazione che gli Stati più poveri sono per ragioni geografiche i più impattati dal cambiamento climatico, sia ad un principio di responsabilità storica e di equità nelle possibilità di sviluppo. La seconda idea cardine della COP, invece, è nuova: in passato, infatti, le conferenze dell’UNFCCC sono state criticate perché non è stato dato sufficiente spazio ai report scientifici e ai dati; un passo avanti, dunque.
Dopo questa introduzione, viene subito presentato l’obiettivo più scottante, letteralmente: la riduzione delle emissioni di gas serra e il contenimento del riscaldamento globale. L’obiettivo è azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050 e puntare a limitare l’aumento delle temperature medie a 1,5°C dai livelli preindustriali; per farlo, ogni Stato deve presentare due piani di sviluppo a lungo termine e monitorarne l’applicazione. La COP26 quindi si è proposta di superare gli accordi di Parigi, in cui si dichiarava di voler limitare il riscaldamento al di sotto dei 2°C, preferibilmente intorno a 1,5°C, e non si parlava di azzeramento delle emissioni nette. Queste temperature, che possono sembrare arbitrarie, hanno in realtà una rilevanza scientifica non indifferente. Oggi siamo a 1,1°C dai livelli preindustriali, e possiamo già notare degli effetti di questo riscaldamento. Secondo la maggior parte della comunità scientifica, l’aumento delle temperature di 2°C avrebbe conseguenze ambientali e umane catastrofiche: estinzioni, alluvioni, carestie e ondate di calore diventerebbero la normalità. Se 2°C non sembrano molti, basta pensare che durante il picco dell’ultima era glaciale le temperature medie erano più basse di oggi di circa 6°C.
Gruppo di persone in protesta contro il riscaldamento globale, foto di Mika Baumeister recuperata da Unsplash
Un altro punto di continuità della COP26 con il passato è dato dai dettagli della mobilitazione finanziaria. Gli accordi di Parigi avevano proposto, secondo il principio della responsabilità differenziata, di costituire un fondo globale finanziato dai Paesi più ricchi per sostenere la transizione ecologica degli Stati in via di sviluppo. Le promesse erano di 100 miliardi di dollari annuali, ma non sono state rispettate. Il Glasgow Climate Pact riprende questo progetto e propone di aumentare le cifre versate. Una novità, invece, è data dall’attenzione che per la prima volta viene dedicata al coinvolgimento delle comunità locali e indigene, dei giovani e delle donne, e dall’accento che viene posto sulla preservazione del patrimonio naturale.
A prima vista, quindi, sembra che la COP26 abbia pienamente raggiunto i suoi obiettivi, ma in realtà nasconde moltissime criticità, anche negli aspetti più innovativi e nelle affermazioni più forti. É infatti stato sottolineato come il Glasgow Climate Pact sia il primo accordo del suo tipo che menziona apertamente i combustibili fossili e si impegna a ridurne l’utilizzo; tuttavia la formula è molto ambigua, e a ben vedere si parla soltanto di “carbone non abbattuto” e “centrali poco efficienti”, facendo perdere all’impegno praticamente tutta la sua potenza e significato. Inoltre, un grande punto interrogativo è dato dalla coerenza degli impegni presi con l’obiettivo: non si è ancora certi se i trattati ratificati finora possano mantenere il riscaldamento sotto la soglia prefissata, nemmeno se implementati in modo ottimale e tempestivo; di conseguenza, è molto difficile che la promessa di un aumento delle temperature che resti sotto gli 1,5°C si realizzi.
Un’altra critica quasi scontata deriva dallo scarso impegno di molti Stati in questa causa. I Paesi che più patiscono le conseguenze del cambiamento climatico, ad esempio gli Stati insulari, avevano richiesto un fondo specifico per coprire i danni causati dalle catastrofi naturali alle comunità, ma senza nessun risultato. Un’immagine della COP26 particolarmente forte è quella infatti di Simon Kofe, ministro di Tuvalu (un piccolo Stato insulare nel sud Pacifico, in pericolo per l’innalzamento del livello del mare), che pronuncia il suo discorso da un palco in mezzo al mare, con l’acqua fino alle ginocchia.
Ma la mancanza di impegno non si ferma qui: India e Cina, ad esempio, hanno faticato molto a firmare i trattati, specialmente quelli sui combustibili fossili. Sono infatti rispettivamente il quinto e il primo produttore mondiale di carbone, ma essendo tecnicamente paesi in via di sviluppo hanno meno obblighi. Anche la Russia non ha dimostrato grande impegno, ma per motivi diversi: l’innalzamento delle temperature non è visto come un problema, e lo scioglimento dei ghiacci permette di aprire nuove rotte commerciali. Nemmeno gli Stati sviluppati a noi più vicini sono esenti da critiche, dato che non hanno mantenuto la promessa di 6 anni fa riguardo al fondo globale per il clima. Tuttavia l’ONU, per la sua stessa struttura, non ha potere di imporre sanzioni, e quindi queste violazioni restano impunite.
Qui emerge infatti l’altro grande interrogativo: che senso ha fare accordi che non sono vincolanti, se non è possibile farli rispettare? Sono tutte promesse vuote demandate al “buon cuore” dei singoli Stati, sono tutte chiacchiere?
Climate Crime Scene, foto di Ehimetalor Akhere Unuabona recuperata da Unsplash
Senza alcun dubbio siamo di fronte alla sfida più importante del millennio, da cui dipende il destino di un intero pianeta. Non solo, questa crisi ha forse più di tutte le altre un carattere globale, ed è questo il problema centrale. I nostri strumenti politici, diplomatici, economici sono ancora legati ad un mondo individualista, centrato sui singoli stati ed egoista, mentre quello reale è più che mai globalizzato e interconnesso. La scienza, la politica, il mercato e la cultura sono internazionali, le idee viaggiano veloci grazie ad Internet, e tutta l’umanità sta diventando sempre più un’unica comunità. É giunto il momento di ripensare il modo con cui ci approcciamo al mondo e con il quale dialoghiamo tra di noi, non solo per un principio di equità, giustizia e fratellanza ma semplicemente perché è l’unica strada che possa garantirci un futuro.
La COP26, con le sue contraddizioni, rappresenta entrambe queste visioni del mondo: l’umanità intera che dialoga per risolvere un problema e gli Stati che cercano di seguire ciascuno il proprio interesse. Secondo me, quindi, era prevedibile che i patti stipulati fossero insoddisfacenti, soprattutto considerando il fatto che non c’è un’autorità superiore a fare richieste e regolarne l’applicazione. Tuttavia, sono stati fatti passi in avanti sul piano ideologico e, cosa più importante, il tema del cambiamento climatico acquista ogni giorno più vigore e rilevanza. Le timide promesse fatte alla COP26 rappresentano secondo me degli impegni che ogni Stato prende di fronte ai propri cittadini che, in virtù anche di una maggiore sensibilizzazione, possono e devono chiedere di più.
Cambiare modelli per quanto riguarda lo sviluppo economico e la concezione dei rapporti internazionali è certamente un’impresa titanica di cui gli Stati e le aziende sono gli unici responsabili, e che sicuramente non può realizzarsi in una conferenza di due settimane, ma l’unica spinta per raggiungere questo obiettivo proviene dalla comunità globale. Non sono quindi i rappresentanti politici i veri leader di questa lotta, ma i comuni cittadini che attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e la critica instancabile reclamano il proprio diritto di vivere in modo sostenibile e rispettoso sul nostro pianeta, il “pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto“.
(Pale Blue Dot, Voyager 1, Wikimedia Commons)
(In fotografia: il Pale Blue Dot, la Terra vista dallo spazio ad una distanza di 6 miliardi di chilometri, ai confini del Sistema Solare)
© Nadir – il blog degli studenti del Collegio Mazza – Autore: Gaia Brambilla